|
ORIGINI ED EVOLUZIONE DELLA RAZZA CHIANINA
E’ una delle più importanti
ed antiche razze bovine d’Italia. Conosciuta ed apprezzata fin
dall’antichità: Etruschi e Romani usavano animali dal candido manto nei
cortei trionfali o per i loro sacrifici agli déi (Marchi, 1906). Tra le
righe degli scritti di Columella e Virgilio, si legge come al loro tempo
le carni erano destinate alla tavola di pochi privilegiati, in quanto il
loro primo utilizzo era legato al lavoro nei campi, per trainare
l’aratro o per spostare grossi massi, comunque sia per lavoro di fatica
che risultavano essere particolarmente adatti per questo tipo di
animale. In numerosi scavi effettuati in Umbria e Toscana sono venuti
alla luce vasi, cornicioni, monete raffiguranti bovini o teste di bovini
molto somiglianti ai Chianini specialmente per quanto concerne la testa
leggera e brachicefala con corna piccole. Il “toro italico”, rame
monetario del Lazio databile intorno ai primi anni del IV secolo a.C.,
presenta proprio le caratteristiche di un Chianino (Giuliani, 1954). In
seguito al dominio romano, l’allevamento si estese dall’Arno al Clitunno,
le cui limpide acque, dice la leggenda, rendevano candido il mantello di
questi animali. Con il Cristianesimo, i buoi bianchi persero la loro
funzione sacrificale, e venne meno anche la pratica dell’allevamento. Si
verificò così il ritorno allo stato brado degli animali, che causò la
scomparsa dei caratteri gentili a vantaggio della rusticità. Nell’‘800,
vista la grande mole che rendeva la Chianina alquanto adatta al lavoro,
divenne indispensabile collaboratrice dell’agricoltore: così in questo
periodo la dote più apprezzata era l’attitudine al lavoro, tanto che i
buoi venivano usati per il lavoro dei campi e per il traino di carri e
calessi. La produzione di carne era quindi poco considerata, in quanto,
già con il lavoro, gli animali ripagavano l’agricoltore dei costi
sostenuti per il loro mantenimento.
carni erano destinate alla tavola di pochi privilegiati, in quanto il
loro primo utilizzo era legato al lavoro nei campi, per trainare
l’aratro o per spostare grossi massi, comunque sia per lavoro di fatica
che risultavano essere particolarmente adatti per questo tipo di
animale. In numerosi scavi effettuati in Umbria e Toscana sono venuti
alla luce vasi, cornicioni, monete raffiguranti bovini o teste di bovini
molto somiglianti ai Chianini specialmente per quanto concerne la testa
leggera e brachicefala con corna piccole. Il “toro italico”, rame
monetario del Lazio databile intorno ai primi anni del IV secolo a.C.,
presenta proprio le caratteristiche di un Chianino (Giuliani, 1954). In
seguito al dominio romano, l’allevamento si estese dall’Arno al Clitunno,
le cui limpide acque, dice la leggenda, rendevano candido il mantello di
questi animali. Con il Cristianesimo, i buoi bianchi persero la loro
funzione sacrificale, e venne meno anche la pratica dell’allevamento. Si
verificò così il ritorno allo stato brado degli animali, che causò la
scomparsa dei caratteri gentili a vantaggio della rusticità. Nell’‘800,
vista la grande mole che rendeva la Chianina alquanto adatta al lavoro,
divenne indispensabile collaboratrice dell’agricoltore: così in questo
periodo la dote più apprezzata era l’attitudine al lavoro, tanto che i
buoi venivano usati per il lavoro dei campi e per il traino di carri e
calessi. La produzione di carne era quindi poco considerata, in quanto,
già con il lavoro, gli animali ripagavano l’agricoltore dei costi
sostenuti per il loro mantenimento.
In un secondo
tempo la selezione fu orientata ad un maggiore equilibrio fra attitudine
al lavoro e produzione di carne. Scomparve l’allevamento brado a favore
di quello stallino, a cui si abbinò un’alimentazione migliore; il manto
andò via via schiarendo fino ad acquistare il suo vantato candore.
(Tratto da “ La Valle dei Giganti”
op.c)
Dal 1900 si iniziò una selezione morfofunzionale, la quale portò la
razza Chianina ad essere ammirata ovunque per le sue qualità e
caratteristiche; era una delle poche razze rimaste pure e, poiché aveva
forti potenzialità produttive, si cercò con essa di migliorare le altre
razze bovine di altre regioni. Questi bovini si diffusero soprattutto
nella
Toscana,
nell’Umbria, in parte delle Marche e del Lazio, in quanto anche qui vi
era una larga conduzione di terreni a mezzadria e perché proprio per tr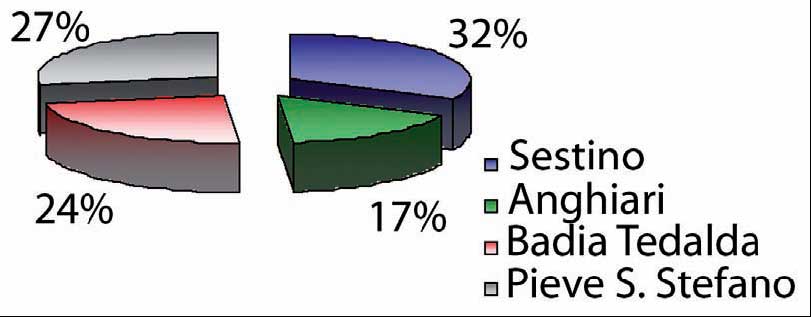 adizione
vi erano dei bravi allevatori. Negli anni ‘60, con il grande sviluppo
della meccanizzazione agricola, la funzione di animale da lavoro diminuì
drasticamente, così da favorire essenzialmente la produzione di carne. adizione
vi erano dei bravi allevatori. Negli anni ‘60, con il grande sviluppo
della meccanizzazione agricola, la funzione di animale da lavoro diminuì
drasticamente, così da favorire essenzialmente la produzione di carne.
Negli anni
’90, in particolare, la crisi del settore zootecnico, ha comportato il
tradizionale allevamento in stalla a stabulazione fissa antieconomico,
per cui si è reso necessario il recupero di quei caratteri di rusticità
ed attitudine al pascolo, utili per l’allevamento brado e semibrado;
oggi si cerca di migliorare la velocità di accrescimento e lo sviluppo
delle masse muscolari, al fi ne di ridurre il costo di produzione del
chilogrammo di carne.
LA RICERCA
DELLA QUALITA’
Lo scopo
della selezione e del miglioramento genetico, articolati sulla base
della genealogia, sono sempre stati il punto fermo egli studi per il
mantenimento della purezza della razza Chianina e quindi delle sue
indiscusse qualità morfofunzionali. Nel 1966 si costituì l’Associazione
Nazionale Allevatori Bovini Italiani da Carne (A.N.A.B.I.C.)
che mantiene il Libro genealogico della razza Chianina con la vigilanza
del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali.
Attualmente
l’indirizzo selettivo mira alla scelta dei capi che garantiscono una
migliore distribuzione delle masse muscolari con incremento dei tagli
più pregiati. A tal proposito sta lavorando il “Centro per la
selezione di manze chianine al pascolo” a Ponte Presale (Sestino -
Arezzo), attuando una selezione dei maschi bovini in base alla capacità
di accrescimento, muscolosità e resa alla macellazione
CHIANINA E VALTIBERINA:
UN LEGAME NEI SECOLI
E’
storicamente accertato che i bovini di razza chianina sono allevati
nella Valtiberina da 2200 anni, complici indiscusse le ampie superfici a
pascolo che consentono l’alpeggio. A dimostrazione dell’importanza della
razza bovina in Valtiberina Toscana, l’ultimo fine settimana di
settembre, ogni anno a Ponte Presale, viene organizzata la Rassegna della Chianina;
nata come fiera del bestiame
Ponte Presale, viene organizzata la Rassegna della Chianina;
nata come fiera del bestiame
si è evoluta fino ad oggi divenendo una Mostra Nazionale di tutto
rispetto. Organizzata da
APAA e ANABIC,
alla Mostra sono esposti i bovini chianini iscritti al Libro Genealogico
Nazionale; al suo interno si svolge sia una gara dove viene premiato il
miglior esemplare bovino presente, ed un’asta, dove le bestie di miglior
pregio sono oggetto di compravendita da parte degli allevatori presenti.
Intorno all’allevamento della chianina gravita la fetta maggiore
dell’economia di piccoli Comuni come Sestino o Badia Tedalda che hanno
fatto della Chianina uno dei simboli più importanti della propria terra;
Sestino rientra tra l’altro, nell’elenco dei paesi che fanno
parte dell’Associazione “Città della Chianina”, dimostrando come
la passione per un lavoro tanto antico come è quello dell’allevatore,
sia senza dubbio una ricchezza collettiva, che dà un valore aggiunto
alle bellezze della terra Valtiberina.
COME SI
ALLEVA UNA CHIANINA IN VALTIBERINA
I bovini
restano in stalla da metà ottobre a metà maggio, dopo di che, in modo
assolutamente graduale, così da abituare l’animale alla “nuova” vita
allo stato brado, si lasciano pascolare all’aperto per il resto
dell’anno nelle zone di alta collina. Gli animali vengono allattati
naturalmente
dalle madri
fino al momento dello svezzamento e successivamente la base alimentare
consiste in una miscela di mangimi provenienti dalle stesse coltivazioni
degli allevatori concimati tramite materiale organico recuperato in
loco; orzo, mais, vena, favino, soia che, una volta raccolti, sono posti
in ambienti ampi, ben areati in modo tale da evitare la formazione di
muffe che potrebbero compromettere la qualità dell’alimento; l’ingrasso
avviene nell’ambito della realtà di ogni singola azienda.
 Il
bestiame destinato alla produzione delle carni viene ispezionato prima
della macellazione da esperti appositamente addestrati dal Il
bestiame destinato alla produzione delle carni viene ispezionato prima
della macellazione da esperti appositamente addestrati dal
Consorzio Produttori Carne
Bovina Pregiata delle Razze Italiane,
che si occupa della tutela e diffusione dei marchi. Nell’ambito di
aziende medio piccole, come quelle della Valtiberina, a conduzione
familiare, questo è un aspetto fondamentale, in quanto lo scopo primario
è la garanzia di una carne di ottima qualità in cui devono rimanere
inalterate le caratteristiche nutrizionali della carne. Questo è ciò che
viene offerto costantemente al consumatore, per quanto i costi per
allevare in modo serio un solo esemplare di Chianina, coprirebbero
tranquillamente le spese per l’ingrasso di ben due bestie di altra
razza, la filosofi a che vige ferrea tra gli allevatori di carne
chianina della Valtiberina, è sempre e comunque legata alla ricerca
attenta e scrupolosa della qualità. L’indirizzo zootecnico adottato da
tempo nel comprensorio, è risultato il punto di forza del sistema
agricolo, in due aspetti fondamentali: adeguata crescita del reddito in
ambienti rurali difficili e, salvaguardia di un’area ad alto valore
ambientale e paesaggistico. Alla luce di questo il livello organizzativo
va mantenuto e possibilmente potenziato, sia migliorando la
commercializzazione che la capacità produttiva dei soggetti, di entrambi
i sessi, da cui si ricavano carni da esemplari tra i 18 ed i 22 mesi. In
Valtiberina è concentrato oltre il 50% dell’allevamento di razza
chianina della Provincia di Arezzo; le attività zootecniche sono
ritenute le più qualificate sotto un profilo economic o,
motivo per c o,
motivo per c ui
vanno valorizzate e garantite; la creazione di marchi provinciali di
provenienza e qualità, come
“5R”, I.G.P, “Vitellone Bianco dell’Appennino”, marchio
DOC, sono
dunque di primaria importanza per il progredire perpetuo dello sviluppo
agricolo ed economico
del territorio. L’IGP rappresenta l’unico marchio di qualità per le
carni bovine fresche approvato dalla Comunità Europea per l’Italia. I
bovini utilizzati per la produzione delle carni devono rispondere a
condizioni e requisiti stabiliti dal Disciplinare approvato secondo le
norme previste dal regolamento CE 2081/92. Il bestiame deve essere nato
in Italia in allevamenti iscritti al Libro Genealogico Nazionale
al fi ne di consentire la verifica della razza. ui
vanno valorizzate e garantite; la creazione di marchi provinciali di
provenienza e qualità, come
“5R”, I.G.P, “Vitellone Bianco dell’Appennino”, marchio
DOC, sono
dunque di primaria importanza per il progredire perpetuo dello sviluppo
agricolo ed economico
del territorio. L’IGP rappresenta l’unico marchio di qualità per le
carni bovine fresche approvato dalla Comunità Europea per l’Italia. I
bovini utilizzati per la produzione delle carni devono rispondere a
condizioni e requisiti stabiliti dal Disciplinare approvato secondo le
norme previste dal regolamento CE 2081/92. Il bestiame deve essere nato
in Italia in allevamenti iscritti al Libro Genealogico Nazionale
al fi ne di consentire la verifica della razza.
QUALITA’
DELLA CARNE
Il vitellone
possiede la carne più succulenta, nutriente e fortificante e la sua
carne migliore si riconosce dal colore rosso vivo, dalla grana fi ne,
consistente,
 contemporaneamente
soda ed elastica al tocco, dalle piccole infiltrazioni di grasso
(bianche o leggermente biancastre) che solcano la massa muscolare e
dallo spessore esteriore del grasso, di colore bianco o giallo chiaro,
che ricopre la superficie del dorso e dei lombi. Queste sono qualità che
derivano dalla razza dell’animale e dal regime alimentare durante il
periodo di ingrassamento. Per quanto riguarda il contenuto in grassi, la
carne ne contiene in media il 3%, variando da un minino dello 0.5 % ad
un massimo del 7%. Importante pregio della carne è il suo contenuto in
ferro, in forma perfettamente assorbibile dall’organismo. La presenza
dei lipidi totali non supera mai il 2,5% pure a pesi intorno agli 850 kg
(Poli B. M. et al., 1994a). Le carni di Chianina hanno messo in
evidenza, nella componente lipidica, la bassa incidenza di acidi grassi
saturi che, nell’intervallo tra 16 e 24 mesi, raggiunge solo il 44-45%.
Risultano invece elevate, anche ad età avanzate, le quantità degli acidi
grassi linoleico ed arachidonico, preziosi dal punto di vista
nutrizionale. Il rapporto trigliceridi/ fosfolipidi risulta
relativamente costante e basso per tutte le età studiate così come il
livello in colesterolo (Poli B. M. et al, 1994). contemporaneamente
soda ed elastica al tocco, dalle piccole infiltrazioni di grasso
(bianche o leggermente biancastre) che solcano la massa muscolare e
dallo spessore esteriore del grasso, di colore bianco o giallo chiaro,
che ricopre la superficie del dorso e dei lombi. Queste sono qualità che
derivano dalla razza dell’animale e dal regime alimentare durante il
periodo di ingrassamento. Per quanto riguarda il contenuto in grassi, la
carne ne contiene in media il 3%, variando da un minino dello 0.5 % ad
un massimo del 7%. Importante pregio della carne è il suo contenuto in
ferro, in forma perfettamente assorbibile dall’organismo. La presenza
dei lipidi totali non supera mai il 2,5% pure a pesi intorno agli 850 kg
(Poli B. M. et al., 1994a). Le carni di Chianina hanno messo in
evidenza, nella componente lipidica, la bassa incidenza di acidi grassi
saturi che, nell’intervallo tra 16 e 24 mesi, raggiunge solo il 44-45%.
Risultano invece elevate, anche ad età avanzate, le quantità degli acidi
grassi linoleico ed arachidonico, preziosi dal punto di vista
nutrizionale. Il rapporto trigliceridi/ fosfolipidi risulta
relativamente costante e basso per tutte le età studiate così come il
livello in colesterolo (Poli B. M. et al, 1994).
PERCORSO DIDATTICO
SULLA CARNE CHIANINA
(attualmente
in fase di collaudo finale)
 |


 o,
motivo per c
o,
motivo per c ui
vanno valorizzate e garantite; la creazione di marchi provinciali di
provenienza e qualità, come
“5R”, I.G.P, “Vitellone Bianco dell’Appennino”, marchio
DOC, sono
dunque di primaria importanza per il progredire perpetuo dello sviluppo
agricolo ed economico
del territorio. L’IGP rappresenta l’unico marchio di qualità per le
carni bovine fresche approvato dalla Comunità Europea per l’Italia. I
bovini utilizzati per la produzione delle carni devono rispondere a
condizioni e requisiti stabiliti dal Disciplinare approvato secondo le
norme previste dal regolamento CE 2081/92. Il bestiame deve essere nato
in Italia in allevamenti iscritti al Libro Genealogico Nazionale
al fi ne di consentire la verifica della razza.
ui
vanno valorizzate e garantite; la creazione di marchi provinciali di
provenienza e qualità, come
“5R”, I.G.P, “Vitellone Bianco dell’Appennino”, marchio
DOC, sono
dunque di primaria importanza per il progredire perpetuo dello sviluppo
agricolo ed economico
del territorio. L’IGP rappresenta l’unico marchio di qualità per le
carni bovine fresche approvato dalla Comunità Europea per l’Italia. I
bovini utilizzati per la produzione delle carni devono rispondere a
condizioni e requisiti stabiliti dal Disciplinare approvato secondo le
norme previste dal regolamento CE 2081/92. Il bestiame deve essere nato
in Italia in allevamenti iscritti al Libro Genealogico Nazionale
al fi ne di consentire la verifica della razza.
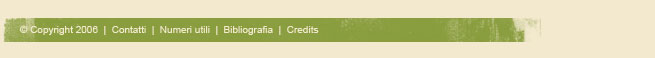
 carni erano destinate alla tavola di pochi privilegiati, in quanto il
loro primo utilizzo era legato al lavoro nei campi, per trainare
l’aratro o per spostare grossi massi, comunque sia per lavoro di fatica
che risultavano essere particolarmente adatti per questo tipo di
animale. In numerosi scavi effettuati in Umbria e Toscana sono venuti
alla luce vasi, cornicioni, monete raffiguranti bovini o teste di bovini
molto somiglianti ai Chianini specialmente per quanto concerne la testa
leggera e brachicefala con corna piccole. Il “toro italico”, rame
monetario del Lazio databile intorno ai primi anni del IV secolo a.C.,
presenta proprio le caratteristiche di un Chianino (Giuliani, 1954). In
seguito al dominio romano, l’allevamento si estese dall’Arno al Clitunno,
le cui limpide acque, dice la leggenda, rendevano candido il mantello di
questi animali. Con il Cristianesimo, i buoi bianchi persero la loro
funzione sacrificale, e venne meno anche la pratica dell’allevamento. Si
verificò così il ritorno allo stato brado degli animali, che causò la
scomparsa dei caratteri gentili a vantaggio della rusticità. Nell’‘800,
vista la grande mole che rendeva la Chianina alquanto adatta al lavoro,
divenne indispensabile collaboratrice dell’agricoltore: così in questo
periodo la dote più apprezzata era l’attitudine al lavoro, tanto che i
buoi venivano usati per il lavoro dei campi e per il traino di carri e
calessi. La produzione di carne era quindi poco considerata, in quanto,
già con il lavoro, gli animali ripagavano l’agricoltore dei costi
sostenuti per il loro mantenimento.
carni erano destinate alla tavola di pochi privilegiati, in quanto il
loro primo utilizzo era legato al lavoro nei campi, per trainare
l’aratro o per spostare grossi massi, comunque sia per lavoro di fatica
che risultavano essere particolarmente adatti per questo tipo di
animale. In numerosi scavi effettuati in Umbria e Toscana sono venuti
alla luce vasi, cornicioni, monete raffiguranti bovini o teste di bovini
molto somiglianti ai Chianini specialmente per quanto concerne la testa
leggera e brachicefala con corna piccole. Il “toro italico”, rame
monetario del Lazio databile intorno ai primi anni del IV secolo a.C.,
presenta proprio le caratteristiche di un Chianino (Giuliani, 1954). In
seguito al dominio romano, l’allevamento si estese dall’Arno al Clitunno,
le cui limpide acque, dice la leggenda, rendevano candido il mantello di
questi animali. Con il Cristianesimo, i buoi bianchi persero la loro
funzione sacrificale, e venne meno anche la pratica dell’allevamento. Si
verificò così il ritorno allo stato brado degli animali, che causò la
scomparsa dei caratteri gentili a vantaggio della rusticità. Nell’‘800,
vista la grande mole che rendeva la Chianina alquanto adatta al lavoro,
divenne indispensabile collaboratrice dell’agricoltore: così in questo
periodo la dote più apprezzata era l’attitudine al lavoro, tanto che i
buoi venivano usati per il lavoro dei campi e per il traino di carri e
calessi. La produzione di carne era quindi poco considerata, in quanto,
già con il lavoro, gli animali ripagavano l’agricoltore dei costi
sostenuti per il loro mantenimento.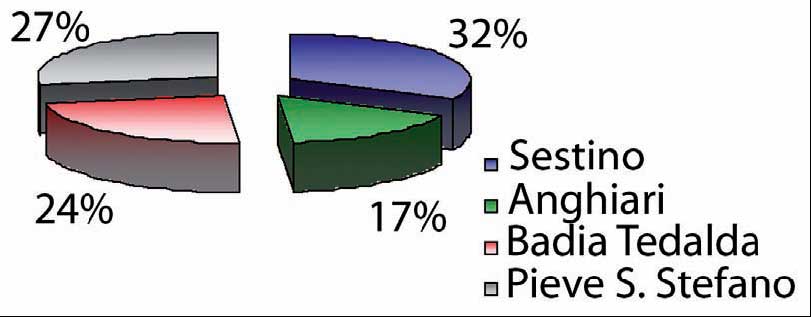 adizione
vi erano dei bravi allevatori. Negli anni ‘60, con il grande sviluppo
della meccanizzazione agricola, la funzione di animale da lavoro diminuì
drasticamente, così da favorire essenzialmente la produzione di carne.
adizione
vi erano dei bravi allevatori. Negli anni ‘60, con il grande sviluppo
della meccanizzazione agricola, la funzione di animale da lavoro diminuì
drasticamente, così da favorire essenzialmente la produzione di carne.
 Ponte Presale, viene organizzata la Rassegna della Chianina;
nata come fiera del bestiame
Ponte Presale, viene organizzata la Rassegna della Chianina;
nata come fiera del bestiame Il
bestiame destinato alla produzione delle carni viene ispezionato prima
della macellazione da esperti appositamente addestrati dal
Il
bestiame destinato alla produzione delle carni viene ispezionato prima
della macellazione da esperti appositamente addestrati dal  contemporaneamente
soda ed elastica al tocco, dalle piccole infiltrazioni di grasso
(bianche o leggermente biancastre) che solcano la massa muscolare e
dallo spessore esteriore del grasso, di colore bianco o giallo chiaro,
che ricopre la superficie del dorso e dei lombi. Queste sono qualità che
derivano dalla razza dell’animale e dal regime alimentare durante il
periodo di ingrassamento. Per quanto riguarda il contenuto in grassi, la
carne ne contiene in media il 3%, variando da un minino dello 0.5 % ad
un massimo del 7%. Importante pregio della carne è il suo contenuto in
ferro, in forma perfettamente assorbibile dall’organismo. La presenza
dei lipidi totali non supera mai il 2,5% pure a pesi intorno agli 850 kg
(Poli B. M. et al., 1994a). Le carni di Chianina hanno messo in
evidenza, nella componente lipidica, la bassa incidenza di acidi grassi
saturi che, nell’intervallo tra 16 e 24 mesi, raggiunge solo il 44-45%.
Risultano invece elevate, anche ad età avanzate, le quantità degli acidi
grassi linoleico ed arachidonico, preziosi dal punto di vista
nutrizionale. Il rapporto trigliceridi/ fosfolipidi risulta
relativamente costante e basso per tutte le età studiate così come il
livello in colesterolo (Poli B. M. et al, 1994).
contemporaneamente
soda ed elastica al tocco, dalle piccole infiltrazioni di grasso
(bianche o leggermente biancastre) che solcano la massa muscolare e
dallo spessore esteriore del grasso, di colore bianco o giallo chiaro,
che ricopre la superficie del dorso e dei lombi. Queste sono qualità che
derivano dalla razza dell’animale e dal regime alimentare durante il
periodo di ingrassamento. Per quanto riguarda il contenuto in grassi, la
carne ne contiene in media il 3%, variando da un minino dello 0.5 % ad
un massimo del 7%. Importante pregio della carne è il suo contenuto in
ferro, in forma perfettamente assorbibile dall’organismo. La presenza
dei lipidi totali non supera mai il 2,5% pure a pesi intorno agli 850 kg
(Poli B. M. et al., 1994a). Le carni di Chianina hanno messo in
evidenza, nella componente lipidica, la bassa incidenza di acidi grassi
saturi che, nell’intervallo tra 16 e 24 mesi, raggiunge solo il 44-45%.
Risultano invece elevate, anche ad età avanzate, le quantità degli acidi
grassi linoleico ed arachidonico, preziosi dal punto di vista
nutrizionale. Il rapporto trigliceridi/ fosfolipidi risulta
relativamente costante e basso per tutte le età studiate così come il
livello in colesterolo (Poli B. M. et al, 1994).